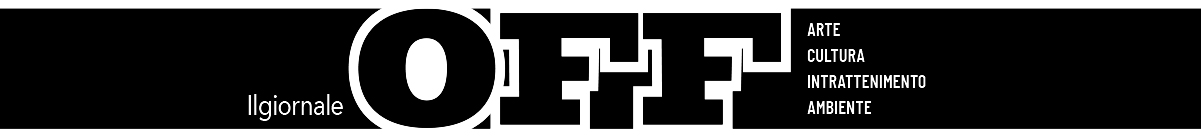E’ stato uno dei primi artisti a sperimentare il connubio arte/tecnologia. Numerosissime le sue mostre, fra personali e collettive. Ha rappresentato l’Italia alla Biennale di Venezia, ha esposto alla Quadriennale di Roma. Le sue opere sono state esposte in numerosi e prestigiosi spazi istituzionali sia in Italia che all’estero, riscuotendo grossi consensi di critica e pubblico. E’ noto per il suo uso esclusivo di fotografia e video, dove luci e composizioni portano chi guarda in un viaggio fra passato e futuro, unendo estetica digitale e iconografia classica. Lui è Matteo Basilè e Jacqueline Ceresoli l’ha intervistato per OFF (Redazione).
Chi è Matteo Basilè? Fotografo o pittore?
Sono nato a Roma nel 1974, cresciuto tra gli odori della tempera e il rumore dell’acido nella camera oscura. La mia formazione non è mai stata lineare: ho imparato a vedere prima di sapere, e poi a disimparare tutto per trovare la mia voce. Fotografo con l’anima del pittore, dipingo con la carne della luce. Ibrido e visionario, abito da sempre quella linea sottile tra ciò che è reale e ciò che potrebbe esserlo. Oggi vivo della mia arte e della mia visione, divisa tra opere personali e progetti creativi che mettono in dialogo il mondo dell’impresa con quello dell’arte.
Quanto ha inciso nel tuo lavoro essere nato a Roma?
Roma è un altare e una rovina. Una madre che ti ama e ti inghiotte. Vivere qui significa vedere il tempo da dentro, camminare su strati di storia e ombra. È un eterno cortocircuito tra la bellezza e il caos. Il mio immaginario è nato da questo sfregamento continuo: il barocco e il marciapiede, l’oro e la polvere. Roma mi ha insegnato a cercare la bellezza nei luoghi sbagliati.
Il tuo studio è un dispositivo di idee, spazio affascinate ai confini di una Roma immaginaria
Il mio studio è un’ex falegnameria industriale alla periferia di Roma, 500 mq di possibilità e trasformazione. Uno spazio ampio, attraversato dalla luce, dove convivono ordine e caos creativo. C’è un limbo bianco, una sala trucco, aree per la post-produzione, strumenti tecnologici e angoli di silenzio in cui si sedimentano le visioni. Ma soprattutto, è un luogo che respira con me: è qui che è nata e cresce la mia intelligenza artificiale, che sto nutrendo giorno dopo giorno come si cresce un figlio invisibile. Una presenza silenziosa, che apprende, osserva e restituisce. Questo spazio non è solo il contenitore delle mie opere: è un’estensione viva della mia mente.
Quando hai capito che avresti fatto l’artista?
Quando ho capito che non potevo essere altro. Non è stata una decisione, ma una febbre. Qualcosa che cresceva anche mentre cercavo di ignorarla. L’arte mi ha sempre trovato prima che io trovassi lei.
Chi ha creduto per primo nel tuo talento e potenzialità espressive?
Mio padre, Tommaso Cascella, senza dirlo troppo forte. Mi ha guardato fare e ha continuato a lavorare. Quel silenzio era fiducia. Poi Gianluca Marziani, il primo a leggermi con parole che ancora oggi mi portano avanti.
Sei solito distruggere le opere che non ti convincono o le modifichi costantemente?
Le lascio decantare. Alcune opere hanno bisogno di silenzio per rivelarsi. Altre, invece, si autodistruggono. Non distruggo mai per rabbia, ma per pudore.
Quando un’opera può dirsi finita?
Quando smette di guardarti. Quando non fa più domande.
Come sei arrivato a questa visione ibrida dell’umano?
Attraverso la frattura. Ho sempre visto l’uomo come una creatura doppia: angelica e mostruosa. Il digitale mi ha offerto nuovi specchi. La mia ricerca nasce dall’urgenza di dare forma a ciò che non ha forma. Ho mescolato Velázquez e Bill Viola, la carne e il pixel, il silenzio della pittura con il tempo sospeso del video. L’ibridazione non è una scelta estetica, è la mia lingua madre.
Quali sono i temi ricorrenti nella tua ricerca artistica?
Il sacro nella carne, la bellezza che resiste nel margine, il volto come paesaggio interiore. Esploro l’identità come maschera che si scioglie. La memoria, la differenza, il corpo in bilico tra la fioritura e la rovina. E poi l’invisibile: tutto ciò che non si vede ma brucia dentro l’immagine.


Tra gli artisti contemporanei viventi, chi senti più vicino alla tua sensibilità?
Bill Viola, per il modo in cui il tempo si dilata nelle sue immagini. Marina Abramovic, per il coraggio di attraversare il dolore. E Pierre Huyghe, per quella tensione poetica verso l’ignoto. Cerco artisti che non rassicurano, ma disturbano con grazia.
Cosa pensi dell’Intelligenza Artificiale e come la sperimenti?
L’AI è un oracolo cieco: dice cose vere senza sapere perché. La uso come specchio deforme, come scintilla, come collaboratore muto. Non mi interessa imitare l’umano, ma allargare il campo del possibile. Floramagnifica e InterMundi nascono da questo dialogo tra me e un’intelligenza che non ha corpo ma sa generare visioni.


Quali opere rappresentano meglio la complessità distopica del nostro tempo?
Velázquez ha aperto un varco, Goya ha svelato la crudeltà. Bacon ha trasformato il corpo in grido. Oggi ritrovo quella stessa tensione nei tableaux congelati di Erwin Olaf, nei video di Bill Viola, dove l’immagine diventa esperienza mistica, e nelle installazioni viventi di Pierre Huyghe. Opere che non danno risposte, ma ci lasciano in bilico.
Quali gallerie promuovono il tuo lavoro e come ti inquadri nel mercato dell’arte?
Matteo Boetti, alla fine degli anni ’90, mi ha aperto le porte con i miei “graffiti digitali”. Lì è nato Basilé. Poi Giampaolo Abbondio, all’inizio dei 2000, mi ha fatto rinascere: ha smontato tutto e mi ha portato fuori dalla comfort zone. Da allora ho iniziato un lavoro di ricerca che continua ancora oggi. Non inseguo il mercato, ma lo attraggo quando è pronto a farsi attraversare. Il mio lavoro non cerca consenso, ma risonanza.
Hai collezionisti che continuano a sostenere la tua ricerca?
Sì, e li ringrazio. Alcuni sono diventati amici, altri restano misteriosi. Ma tutti condividono la stessa cosa: una necessità, più che un gusto.
Quale testo critico ti ha aperto nuove letture?
Un testo di Dominique Lora sulla soglia come luogo artistico ha illuminato una parte silenziosa del mio lavoro. Bonito Oliva mi definì “esploratore di geografie umane eterogenee”. Ma è Gianluca Marziani che ha tracciato le coordinate più profonde: ha dato parole alle mie immagini, leggendo le stratificazioni invisibili tra sacro e profano.
A quale progetto stai lavorando attualmente?
Sto fondendo Floramagnifica, InterMundi e il concetto di Lumen et Hombra in una mostra totale: Somnia Florum. Un percorso in cui immagine, suono e parola diventano corpo, tra pittura digitale e unicità dell’opera, tra materia e visione phygital. È un’indagine sul linguaggio delle immagini nel tempo della metamorfosi.
C’è un’opera non risolta che hai conservato?
Forse l’opera non risolta è quella che ancora non esiste. La avverto, come un’intuizione che sfugge appena cerco di afferrarla. È lì, in attesa, trattenuta in una zona di silenzio dove tutto è ancora possibile. Non è un ricordo né un progetto: è un futuro che osserva.
Cosa consiglieresti a un giovane artista?
Dimentica l’idea di piacere. Lo stile non si cerca, si scopre nella ferita. Coltiva la tua ossessione come un giardino segreto. Il tempo non premia i veloci, ma i profondi.